|
Risposta
al Manifesto
dei docenti universitari ed intellettuali franco-spagnoli contro
la riforma universitaria promossa dal ministri dell'UE
(visibile
qui)
Nota:
Il Manifesto franco-spagnolo critica i tentativi, su scala
europea, di attuare una 'riforma' dell'Università simile
quella proposta dal Ministro Moratti in Italia. Entrambi le
'riforme' mirano cioè:
a
ridurre, attraverso la precarizzazione, il potere dei professori
– in particolare il potere di decidere gli indirizzi di
studio. Cioè, fermo restando la liberà
d'insegnamento nei singoli corsi, con la 'riforma' i professori
avranno meno potere di decidere quale tipi
di insegnamenti e di Corsi di Laurea bisogna privilegiare
all'università;
ad
aumentare il potere del 'mercato' sull'università –
in particolare, il potere di decidere gli indirizzi di studio,
attraverso la graduale riduzione del finanziamento delle
università da parte dello Stato e, nel contempo, un
incremento del finanziamento da parte delle imprese, diretto
verso i settori più 'produttivi'.
Contro
la riforma o controriforma?
Patrick
Boylan
Università
Roma Tre
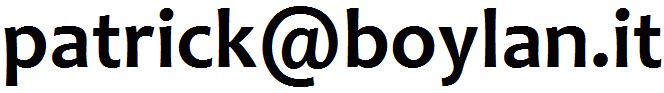
Qui inizia un
discorso difficile.
Difficile perché si rivolge
proprio alla categoria che intende criticare, chiedendole di
mettere in discussione i propri privilegi e persino la propria
buona fede.
Già, avete indovinato: si rivolge
proprio a voi, care lettrici e cari lettori di questo sito, in
quanto donne e uomini di cultura, cioè in quanto
appartenenti ad una élite che, per dirla con Gramsci,
riveste -- in una società da secoli dominata dal modello
ecclesiale -- una funzione politico-sociale compromessa col
potere.
(Il tentativo di
elaborare un discorso di questo tipo mi ha fatto subito capire le
difficoltà delle femministe quando chiedono ai maschi di
riconoscere di godere di privilegi ottenuti con la frode.
Perché la tesi che cercherò di sviluppare qui è
che i nostri privilegi come persone di cultura -- e in
particolare come docenti universitari -- sono stati ottenuti in
virtù di meccanismi sociali che defraudando interi settori
della popolazione, meccanismi di cui forse non siamo consapevoli
perché non abbiamo interesse a venirne a conoscenza, ma
che comunque perpetuiamo. Un po' come avviene con le disparità
di genere.)
Ma
arriviamo subito al dunque: a mio avviso, il Manifesto contro il
progetto di riforma europea dell'istruzione universitaria,
firmato da numerosi intellettuali spagnoli e francesi, va preso
con le pinze.
"Ma come? -- mi direte -- il Manifesto
è contro la privatizzazione delle università in
Europa, contro il loro asservimento al Grande Capitale, contro la
formazione di laureati-robotini da inserire nelle catene di
produzione. Come si fa ad avere delle riserve su una critica così
condivisibile?"
Un momento! Condividerei senz'alcun
dubbio l'appello e firmerei subito il Manifesto se io insegnassi
in una università francese, tedesca, o inglese (non
conosco il ruolo sociale delle università in Spagna).
Ma
insegno in una università italiana. E in Italia la
situazione è diversa.
Qui si è creata,
attraverso i secoli, una docenza universitaria che emula il
sacerdozio, una casta di chierici predicatori che, soprattutto
nel settore umanistico, usa la cultura come una clava, non per
istruire le masse ma per metterle al loro posto, per far loro
capire la loro abissale ignoranza e la distanza che le separa dal
Sapere. Naturalmente, non bisogna fare di ogni erba un fascio; ci
sono docenti diversi, anche facoltà intere diverse,
soprattutto nelle "scienze dure". Sto parlando di una
particolare funzione politico-sociale di un certo modello di
università inserita in un determinato tipo di società.
Quale?
In Italia si leggono meno libri di qualsiasi altro
paese industrializzato; le biblioteche sono meno utilizzate (dò
soltanto questi due indizi ma ce ne stanno tanti): allora è
fuori discussione che qui la cultura altamente mediata -- quella
che si diffonde attraverso la lettura di testi "seri" e
che contraddistingue coloro che occupano i posti di rilievo -- è
appannaggio di pochi. Non di tanti, non delle masse. Mentre in
Francia, in Germania, in Gran Bretagna, con tutti i loro
squilibri interni, le cose non sono a questi livelli. La gente
legge. Le biblioteche sono piene. Il tasso di scolarità è
alto. L'analfabetismo di ritorno è scarso. Il numero di
laureati è due o tre volte la cifra italiana.
Allora
bisogna riconoscere che qualcosa non funziona nel sistema di
formazione nel Belpaese. Qualcosa di strutturale, poiché
la frattura tra colti e popolo, per quanto molto attenuata oggi
grazie alla scolarizzazione di massa e l'apertura dell'Università
a tutti i diplomati, esiste da secoli e da sempre assolve a
medesima funzione politico-sociale.
E siccome gli
insegnanti della scuola ricevono la loro formazione principale
dall'Università, il centro di riproduzione dei meccanismi
sociali di esclusione, per quanto essi iniziano sin dalla scuola,
va ricercato proprio nell'insegnamento universitario. Proprio nei
corsi che dichiarano di voler conservare e trasmettere il Sapere
e le tradizioni.
Insisto su questo punto. Se l'università
crea distanze anziché colmarle, la colpa principale non va
imputata ai finanziamenti sempre insufficienti o agli organici
amministrativi sempre carenti. La colpa sta nell'attuazione,
seppure inconsapevole, di un disegno culturale complessivo in cui
l'Università si inserisce: quello del mantenimento della
cultura alta in mano a pochi eletti, poiché (secondo
questa tradizione) solo loro possono apprezzarla e coltivarla.
In questo tipo di società, dunque, l'intellettuale
elitario è funzionale al mantenimento dello status quo:
Gramsci dà a questa casta il nome di "intellettuali
tradizionali", la cui funzione è quella di curare le
sovrastrutture già consolidate, di mantenere (anziché
colmare) le distanze tra colti e plebe, di servire da diaframma
tra chi comanda e chi esegue.
In Italia questa casta è
stata straordinariamente efficace: come dicevo, basta guardare il
poco utilizzo delle biblioteche, il basso numero di lettori di
libri, l'analfabetismo di ritorno, la bassa scolarità
rispetto agli altri grandi paesi industrializzati, il numero di
laureati due o tre volte inferiore agli altri paesi europei.
Quindi si tratta di una casta che, malgrado le sue proclamazioni
ufficiali di voler diffondere la Cultura su larga scala, nei
fatti mette le masse al loro posto e contribuisce con ciò
a frenare le contestazioni dal basso.
Il "basso",
poi, consiste in niente di meno del 91% della popolazione adulta
lavorativa, cioè tutti coloro che non hanno la laurea
(dati OCSE) e che, in ossequio ad un'usanza linguistica
sconosciuta o estinta altrove in Europa, sono stati educati a
dire "dottore, dottoressa" quando si devono rivolgere
al 9% degli italiani che invece ce l'ha: il 9% che occupa tutti i
posti di rilievo. Del resto, tra il 91% dei non laureati, il 64%
-- quasi due italiani su tre -- non ha nemmeno la maturità
(dati OCSE). Si tratta dunque di gente che non ha imparato a
leggere tra le righe o ad analizzare dati statistici. Messa
davanti a questioni complesse, tende, a meno di non essere
politicizzata, ad alzare le spalle e a dire: "Boh, forse non
capisco realmente come stanno le cose, lascio che decida il prete
o il prof o l'esperto o chi per loro." "Chi per loro"
è, naturalmente, il ceto dominante.
Ma i danni si
misurano anche in termini economici nazionali: che contributo può
dare questo 64-91% della popolazione adulta (a seconda della
professionalità richiesta) ad un'economia terziaria
avanzata? Ovviamente nulla.
Paradossalmente, gli
intellettuali tradizionali contribuiscono a sorreggere questo
status quo elitario anche quando, da sinistra, dicono di
contestarlo, poiché il loro linguaggio colto e forbito
risulta comprensibile solo a loro stessi o agli intellettuali
tradizionali di destra (che ovviamente non hanno interesse a
cambiare le cose). Le masse, tagliate fuori, possono solo
origliare, come i devoti ad una messa di rito ortodosso.
Defraudati e zittiti erano, defraudati e zittiti rimangono. Ma
c'è di più. Dal momento che non sentono dalla
sinistra un linguaggio intellettualmente rigoroso eppure
idiomatico e sentito (il "linguaggio della gente" che
Gramsci chiamava "nazional-popolare"), prestano
l'orecchio al linguaggio nazionalista e populista della destra,
il quale non fa altro che rinsaldare, dal basso, il divario
colti/plebe. Questo linguaggio, infatti, non eleva la gente
culturalmente, anzi l'invischia nei luoghi comuni; tuttavia
cattura l'attenzione perché comprensibile istantaneamente.
E' il fast food della comunicazione: fa passare subito la
fame di sapere, anche se non nutre.
All'università
è la stessa cosa: per i docenti tradizionali, anche di
sinistra, non esistono alternative (che siano culturalmente
qualificate) alle loro lezioni-conferenze, espresse in un
linguaggio forbito che spesso passa sopra la testa di molti
studenti. E se un collega tenta di fare lezioni basate
prevalentemente sulle discussioni guidate tra gruppi di studenti,
per alzare le loro capacità riflessive/espressive, egli
viene tacciato di demagogia. In quanto ai programmi di studio
universitari, non vengono adottati manuali divulgativi -- cosa
peraltro giusta, in quanto i manuali sono una forma di fast
communication anch'essi -- ma, con poche eccezioni, non
vengono adottati nemmeno testi qualificati scritti dai docenti
stessi PER GLI STUDENTI, tenendo conto
del loro bagaglio culturale di partenza e del loro linguaggio. La
maggior parte dei docenti preferisce adottare libri e saggi
scritti da colleghi per altri colleghi: conversazioni tra dotti
che gli studenti possono solo origliare (spesso a stento). Di
nuovo, una messa di rito ortodosso. Non c'è dubbio che uno
studente universitario debba imparare a cogliere ANCHE
discorsi tra specialisti: ma molti non impareranno a farlo se
vengono sottoposti SOLTANTO a discorsi
tra specialisti.
La soluzione?
Agli "intellettuali
tradizionali" (in particolare agli opinion maker,
gran parte dei quali, diversamente dalla Francia o dalla Gran
Bretagna, percepisce anche uno stipendio come professore
universitario), Gramsci contrapponeva "l'intellettuale
organico": organico alle masse, organico al partito e
organico alla produzione.
"Cos'hai detto?!" --
esclameranno a questo punto alcuni tra i docenti universitari che
leggeranno queste righe e che, pur essendo italiani e persone di
cultura. di Gramsci sanno solo i consigli ai figli di "studiare
bene", puntualmente riportati nelle antologie scolastiche.
"Hai detto un intellettuale che sia organico alla...[qui si
turano il naso]... 'produzione'?!? Non si dica mai! Noi
difendiamo la Cultura e la Scienza Disinteressate"
(tradotto: vogliamo fare ciò che ci pare -- c'è
libertà d'insegnamento, no? -- e se i nostri laureati
saranno quasi tutti dei disoccupati, peggio per loro, noi ci
occupiamo solo di quegli studenti che possono permettersi studi
'disinteressati').
Risultato: alcuni picchi d'eccellenza
nell'università italiana, senza dubbio, ma un basso
livello d'istruzione superiore nel paese e, riguardo all'attività
scientifica condotta all'interno delle università, molti
studi, molte ricerche, quindi molti insegnamenti finalizzati a
beghe interne, a campanilismi intellettuali e a interessi di
clan.
Manca -- come punto di riferimento costante per
dipanare le beghe e ri-indirizzare gli interessi -- la pressione
di una richiesta autentica di sapere, che esiste sì nella
società e che spesso viene espressa dagli stessi studenti
(per quanto non sempre in forma articolata), ma che viene in gran
parte ignorata da una università puramente
autoreferenziale.
Sia ben chiaro: non si chiede
all'università d'insegnare "mestieri" ma di dare
una formazione culturale approfondita che sia anche
spendibile. Le due cose possono conciliarsi e le università
lo sanno perfettamente: con la riforma del 2000 hanno creato
molte lauree nuove, alettanti, che promettono proprio questo
binomio. Purtroppo, spesso si tratta di operazioni di pura
maquillage: nei "nuovi" programmi, i corsi sono
prevalentemente quelli di prima, insegnati come prima (o comunque
nella stessa tradizione).
Un esempio per tutti:
per decenni "imparare le lingue" all'università
voleva dire imparare a commentare in italiano testi
letterari in lingua e a spiegare le regole grammaticali di
quella lingua. Ora con i "nuovi" programmi vuol dire
imparare (come prima) a commentare in italiano testi
letterari in lingua e (ecco la novità) a commentare la
struttura e la storia di quella lingua.
Ma continua a
NON voler dire imparare le lingue
ANCHE in quanto vive. Cioè,
continua a NON voler dire imparare a:
relazionarsi
in lingua (il che include ma va ben oltre imparare a
"conversare" in lingua);
negoziare
in lingua (il che include ma va ben oltre imparare ad "esprimere
le proprie idee" in lingua);
cogliere
la forma mentis culturale di un interlocutore straniero
interagendo in lingua: conoscenza umanistica di grande rilievo
culturale e, nel contempo, richiestissima dal mondo del lavoro
(nonché dalla maggior parte degli studenti che si
iscrivono a lingue).
Purtroppo
in tre decadi ho sentito un'unica risposta a questa richiesta
pressante di saperi linguistici nuovi nel Corso di Laurea in cui
insegno: picche. Solo il saper commentare brani letterari e
strutture linguistiche costituirebbe "cultura", proprio
in quanto si tratta di un sapere con una lunga tradizione
esegetica, disinteressato, non organico alla produzione.
Ecco
perché vedo problematico il far battaglia, in Italia, per
una università che si vanta di non avere legami con il
mondo della produzione. I miei studenti devono pur lavorare, non
sono figli di papa.
E, soprattutto, NON
C'E' DICOTOMIA REALE TRA IL SAPERE E IL SAPER FARE.
Questa dicotomia manichea è un'invenzione degli
intellettuali tradizionali per non doversi sporcare le mani.
Gramsci ha ragione. DEVI essere capace
di incidere tecnicamente sui reali processi di produzione
(produzione di beni e di servizi come produzione di idee e di
visioni in quanto risposte, anch'esse, ad esigenze conoscitive
reali) se li vuoi capire criticamente. Senza questa capacità,
vendi fumo. DEVI capire la tua storia
ma la devi capire come RICOSTRUZIONE VOLUTA DALLA
SOCIETA' DI CUI FAI PARTE, i cui meccanismi di
produzione e di diffusione di beni culturali e materiali vanno
padroneggiati, per poter analizzare il proprio patrimonio in modo
corretto. Proprio come faceva Gramsci: linguista di formazione ma
linguista che ha saputo incidere sulla sua società perché
anche economista, filosofo, sociologo, pubblicista, giurista,
storico, oratore ed acuto conoscitore della gestione aziendale,
dell'organizzazione politica e via discorrendo.
Ecco
perché temo che far battaglia in Italia in favore del
Manifesto rischi di fare il gioco di chi vuole difendere lo
status quo e, con esso, la casta degli intellettuali
tradizionali, diaframma fra la gente e il sapere in quanto
modalità del potere.
Certo, oggi chi comanda ha
bisogno di un numero più limitato di intellettuali
tradizionali, in quanto utilizza massicciamente i media per
creare il consenso. Perciò, le frange meno protette di
questa casta cominciano ad essere soppresse oppure riciclate per
soddisfare le nuove esigenze produttive tipiche di una knowledge
society: letteratura, pedagogia, estetica erano discipline,
ora sono businesses per creare fiction, training,
design.
Infatti, la nostra società
terziaria avanzata richiede sempre più intellettuali
organici, non quelli tradizionali. Solo che chi comanda li vuole
organici unicamente alla produzione, non alle masse come
auspicava Gramsci e tanto meno ad un movimento che pone in
discussione i rapporti sociali attuali. Donde il boom delle
università private, nonché i tentativi, denunciati
nel Manifesto, di "privatizzare" le università
statali. Chi comanda vuole garantirsi che fiction,
training e design vengano insegnati unicamente come
"mestieri".
Invece
potrebbero essere insegnati, in un corso universitario che mira a
formare intellettuali integrali, sia come RIFLESSIONI
SULL'UOMO IN UN UNIVERSO DI VALORI (ciò
che fanno da sempre i corsi di letteratura, pedagogia, estetica),
sia come PREPARAZIONE
OPERATIVA EFFETTIVA (ciò
che le università pubbliche rifiutano di fare, dando
quindi al Grande Capitale la scusa di privatizzarle o di
ridimensionarle).
Perciò è vero: gli
intellettuali tradizionali sono ormai effettivamente sotto tiro.
Tuttavia nell'università italiana questa casta conserva
ancora le sue funzioni e le sue prerogative, per quanto intaccate
ogni giorno di più. Bisogna portarle soccorso o esigere
che cambi? E se deve cambiare, in che senso? That is
the question.
La mia risposta, l'ho
appena dato: non bisogna dar battaglia semplicisticamente, come
sembra fare il Manifesto, per soccorre una Università che
non cambia, in quanto una vittoria -- almeno in Italia -- non
farebbe altro che perpetuare l'istruzione superiore elitaria e la
dequalificazione educativa dei molti. Una siffatta vittoria, del
resto, sarebbe perfettamente coerente con il progetto
Berlusconi-Moratti di ridurre l'Italia ad un paese di camerieri
per il turismo, un'Italia di poche persone realmente istruite,
un'Italia in cui si fa poca ricerca e dove l'insegnamento per le
masse è, appunto, dequalificato. "Intanto, le masse
devono solo servire" -- cioè servire dio (dice quella
parte della Chiesa che asseconda il progetto), servire i turisti
(dice la rendita parassitaria), servire la funzionalità
del sistema (dicono i politici di turno e tutti quelli che,
sfruttando i loro privilegi come donne e uomini di cultura, hanno
sempre campato bene in un'Italia ultima nelle classifiche per i
livelli d'istruzione popolare).
Ma la cultura (come la
democrazia) di un paese non si misura dalla capacità di
pochi di interpretare criticamente la realtà e di
elaborare raffinati strumenti di analisi e di rappresentazione,
ma dalla capacità delle masse in quel paese di farlo. Il
Rinascimento si è distinto dai secoli precedenti non per i
geni che ha prodotti (intanto, il '200 ha prodotto Dante
Alighieri, il più grande di tutti) ma per la diffusione
della cultura a strati sempre più ampi. Dante errava da
regione in regione alla ricerca di chi lo poteva capire, mentre i
grandi artisti del Rinascimento avevano botteghe piene di addetti
per soddisfare le incessanti richieste di opere innovative. La
forza del Rinascimento è stata nell'ampiezza della
produzione e della distribuzione di prodotti culturali e di
manufatti d'ingegno -- cioè, malgrado le apparenze, nel
suo anti-elitarismo.
Oggi in Italia, invece, la casta incaricata di formare le
giovani generazioni, almeno nel settore umanistico, si difende
dai progetti mercantili di riforma universitaria chiudendosi nel
suo guscio e riproducendo l'elitarismo responsabile per i tristi
dati sull'utilizzo delle biblioteche in Italia o sul numero di
libri letti ogni anno o sulla competitività del paese nel
settore terziario avanzato. Questa sua scelta, dunque, non va
sostenuta. Va contestata. In che modo? Per non perdere il
patrimonio di cultura di cui questa casta detiene effettivamente
il monopolio, essa andrebbe incentivata a preparare,
contrariamente alle sue abitudini, masse di intellettuali
organici, tra i cui ranghi scegliere -- non esclusivamente ma
prevalentemente -- le nuove leve di docenti universitari.
Andrebbero quindi premiate le facoltà che programmano per
indirizzi (non per cattedre), favorendo quelli nuovi. Tramite
opportuna legislazione, andrebbero incoraggiati passaggi a
settori innovativi affini, disattivando il vecchio insegnamento.
Andrebbe penalizzata la duplicazione di insegnamenti poco
frequentati (o con alti rapporti docente/studenti) presso due
università dello stesso territorio. Andrebbero
riconosciuti prioritariamente nei concorsi periodi d'insegnamento
(e non solo di ricerca) presso università estere celebri
per i loro programmi didattici
innovativi nel settore.
Premesso tutto ciò che
precede, posso allora dichiararmi d'accordo con il Manifesto nel
respingere il tentativo del Grande Capitale europeo
(rappresentato da Giscard nella stesura della Costituzione) di
cambiare le università UE sul modello USA, dove
effettivamente la maggior parte dei finanziamenti universitari
viene dalle società private, quindi dove si produce un
sapere finalizzato in gran parte alla produzione ACRITICA
di saperi "industrializzati" secondo un pragmatismo di
bassa lega che non ha nulla a che vedere con il pragmatismo
teorizzato da Dewey (volutamente ignorato proprio perché
autenticamente empowering).
Ma
nel dire no a Giscard, dobbiamo offrire un'alternativa che non
sia il mantenimento dello status quo. Ecco la ragione della
proposta appena fatta: un sistema universitario europeo che
formi, accanto ad un certo numero di intellettuali tradizionali,
un numero superiore di intellettuali gramsciani, cioè
intellettuali a 360° che sono anche
organici alla produzione. E che, in Italia, alzano effettivamente
il livello d'istruzione del 91% del paese che NON
ha la laurea, non solo perché essi possiedono una visione
integrale dei saperi ma anche perché, lavorando in TUTTI
gli strati sociali, disseminano quanto appreso all'università.
(Invece una recente indagine della Fondazione Debenedetti ha
rivelato che per la stragrande maggioranza dei laureati italiani
nel settore umanistico, quanto è stato insegnato loro
all'università NON
è servito nelle successive attività lavorative.
Certo, la cultura non deve "servire" per arricchire, ci
mancherebbe altro! Ma fa riflettere il dato che, nelle più
diverse attività lavorative di centinaia di migliaia di
laureati in Lettere e persino in Lingue, quanto appreso
all'università non sia affatto servito.)
Ben
inteso, ci sarà inevitabilmente una certa élite
anche nel tipo di sistema universitario descritto qui. Una parte
dei futuri intellettuali -- organici o tradizionali --
acquisteranno saperi complessi pienamente comprensibili soltanto
ad altri specialisti e che rimarranno confinati dunque in questo
ambito ristretto. Ma la differenza starà nei molti
laureati (quelli che oggi mancano) i quali, diffondendo in tutti
gli ambiti lavorativi quanto essi hanno imparato all'Università,
risveglieranno la società complessivamente. Come nel
Rinascimento, le biblioteche si moltiplicheranno e il numero di
libri in circolazione aumenterà notevolmente. Sarà
però un Rinascimento di ancora più vaste
dimensioni: l'Internet, ad esempio, sarà utilizzato da
tutti per ampliare le proprie conoscenze di fondo e non solo per
l'e-mail o per ricercare notizie spicciole. In una parola,
l'Italia diventerà a pieno titolo una knowledge
society. E, non avendo
parcellizzato quel knowledge
-- come invece avviene nelle università americane e che,
giustamente, bisogna impedire che avvenga nell'UE -- l'Italia
avrà addirittura una marcia in più rispetto agli
Stati Uniti.
Concludo. Come alcuni di noi abbiamo detto
nel '68, nel '78 e nel '90 (la Pantera), la lotta per migliorare
l'università deve essere contro l'università voluta
dal Grande Capitale ma ANCHE
contro l'università d'élite mascherata da
università di massa. "Contro la privatizzazione
dell'università" -- si diceva all'epoca -- "ma
anche contro l'università che è già nelle
mani di un piccolo gruppo di privati, i baroni" (i quali
puntualmente dichiarano che il termine è improprio in
quanto non esistono più 'baroni' nell'università di
oggi).
E' una linea difficile da sostenere perché
hai contro di te tutti.
Hai contro di te il Grande
Capitale a cui piace il discorso di insegnare "capacità
produttive" ma non il discorso di "insegnarle anche
come riflessione sull'essere umano nell'universo in quanto
sistema di valori."
Hai contro di te i colleghi
universitari intellettuali tradizionali, neanche a dirlo, che
vedono i tuoi discorsi solo come un attacco ai loro privilegi e
all'onore della loro casta. Non lo è: gli studi
tradizionali formano benissimo un certo tipo di intellettuale che
ha una sua collocazione sociale necessaria. Ma il problema è
che, per gli intellettuali tradizionali, l'università deve
riprodurre SOLTANTO
la loro casta: sono integralisti che ripudiano la società
pluralistica in cui vivono, inquisitori che bollano di eresia
qualsiasi proposta di diversificare i saperi insegnati.
Hai
contro di te una parte degli studenti: minuscola, è vero,
ma determinata. In teoria questi studenti vorrebbero sì
una università che offra una formazione completa anche ai
compagni che, diversamente da loro, non hanno la vocazione di
intellettuale tradizionale. Solo che... non subito, per favore.
Non prima che si laureino. Non prima che finiscano il dottorato.
Non prima che divengano poi ricercatore universitario. Non
prima...
Hai contro di te solo una piccola minoranza
della popolazione nel suo insieme, ma una minoranza assai
influente -- gli opinion maker,
tutti intellettuali tradizionali. Guai a chi tocca l'idea di
cultura che questi soggetti ritengono di incarnare! Don
Lorenzo Milani scrisse che, per far valere in Italia i diritti
delle masse che non hanno la parola, bisogna combattere un solo
partito: il partito dei laureati. Un partito trasversale che
comprende solo il 9% dell'intera popolazione ma che lotta a denti
stretti per conservare immutata la propria identità
culturale -- che fa egocentricamente coincidere con quella della
Nazione -- in quanto, malgrado tutti gli anni di fatica sui
banchi della scuola e dell'università, non ha imparato ad
adattarla ai tempi.
Quindi la lotta è dura.
Bisogna intraprendere un vero kulturkampf,
una battaglia per estirpare dalla società di cui facciamo
parte proprio i privilegi ecclesiali di cui noi -- in quanto
appartenenti alla piccolissima casta dei laureati -- siamo i
fruitori esclusivi. E bisogna cominciare estirpando anzitutto la
nostra visione elitaria del sapere, che ci sembra così
naturale poiché inculcata sin dalla prima elementare, ma
che invece strangola il paese, impedendo alla gente comune,
dotata di grandissime potenzialità creative, di
realizzarsi appieno (a meno di non emigrare per poterlo fare
altrove).
Il Manifesto è giusto, dunque; ma in
Italia va preso con le pinze perché facilmente
strumentalizzabile da chi vuole mantenere lo status quo. Qui
bisogna rimboccarsi le maniche e condurre una lotta su due
fronti, contemporaneamente.
|